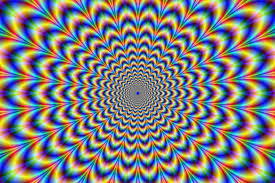Come psicologa che pratica l’ipnosi, una delle domande che mi viene posta più frequentemente è:
“Dottoressa, ma se io non riesco ad andare in ipnosi?”
Questa preoccupazione è comprensibile e molto più comune di quanto si possa pensare. La ricerca scientifica ci mostra infatti che circa il 15-20% della popolazione presenta quella che viene definita “bassa suscettibilità ipnotica”, ma questo non significa affatto che l’ipnosi sia per loro preclusa.
E’ fondamentale sfatare un mito persistente: l’idea che esistano persone completamente “non ipnotizzabili”. Gli studi neurobiologici condotti da Hoeft e colleghi nel 2012 hanno dimostrato che la capacità di entrare in trance è legata a specifiche caratteristiche neuroanatomiche, in particolare alla connettività tra la corteccia prefrontale dorsale e la corteccia cingolata anteriore. Tuttavia, questo non rappresenta un limite invalicabile, ma piuttosto un punto di partenza per personalizzare l’approccio terapeutico. La ricerca di Lynn e Green del 2011 ha evidenziato come la suscettibilità ipnotica possa essere modificata attraverso tecniche specifiche e un approccio graduale. Questo significa che anche chi inizialmente presenta difficoltà può sviluppare la capacità di accedere a stati di trance utili.
Per affrontare efficacemente le difficoltà ipnotiche, è essenziale comprendere cosa accade nel cervello durante la trance. Gli studi di neuroimaging condotti da Oakley e Halligan nel 2013 hanno mostrato che l’ipnosi coinvolge una rete cerebrale complessa che include il giro cingolato anteriore, la corteccia prefrontale e le regioni parietali. Quando un paziente “non riesce” ad andare in ipnosi, spesso si tratta di un’iperattivazione delle aree prefrontali che mantengono un controllo eccessivo sui processi automatici. Questa comprensione neurobiologica ci permette di sviluppare strategie mirate. Come spiego spesso ai miei pazienti, è come se il loro cervello fosse un pilota automatico che ha difficoltà a “cedere il controllo” al copilota. Il nostro compito è creare le condizioni per facilitare questo passaggio in modo graduale e rispettoso.
Strategie cliniche per superare le resistenze
La ricerca di Cardeña e Terhune del 2014 ha dimostrato l’efficacia di un approccio graduale che inizia con tecniche di rilassamento progressivo prima di introdurre elementi ipnotici più specifici. Con i pazienti che presentano resistenze, inizio sempre con esercizi di mindfulness e respirazione consapevole, che sono neurobiologicamente simili alla trance ma psicologicamente meno “minacciosi”. Un esempio concreto è rappresentato da Maria, una paziente di 45 anni che si rivolgeva a me per l’ansia sociale. Nelle prime sedute, ogni tentativo di induzione ipnotica provocava in lei una reazione di ipervigilanza. Abbiamo quindi iniziato con semplici esercizi di respirazione, per poi introdurre gradualmente elementi di immaginazione guidata. Dopo otto sedute, Maria riusciva a raggiungere stati di trance profonda ed efficace.
Una strategia particolarmente efficace è l’impiego della “trance vigile” o “ipnosi ad occhi aperti“, sviluppata da Bányai e Hilgard negli anni ’70. Questa tecnica risulta particolarmente utile per i pazienti che associano l’ipnosi alla perdita di controllo. La ricerca di Bányai del 2018 ha confermato che questa modalità può essere altrettanto efficace dell’ipnosi tradizionale per molte applicazioni cliniche. Durante la trance vigile, il paziente mantiene gli occhi aperti e può muoversi liberamente, riducendo così l’ansia legata alla perdita di controllo. Questo approccio mi ha permesso di lavorare efficacemente con pazienti che presentavano fobie specifiche legate al rilassamento o claustrofobia.
Gli studi di Yapko del 2012 hanno evidenziato come la scelta delle parole e la struttura del linguaggio possano influenzare significativamente la capacità di entrare in trance. Con i pazienti resistenti, evito termini come “ipnosi” o “trance” nelle fasi iniziali, preferendo espressioni come “rilassamento guidato” o “immaginazione”. La ricerca psicolinguistica mostra che le persone con alta attivazione dell’emisfero sinistro rispondono meglio a induzioni strutturate e logiche, mentre quelle con prevalenza dell’emisfero destro preferiscono approcci più creativi e metaforici. Questa personalizzazione del linguaggio può fare la differenza tra successo e insuccesso.
Un aspetto spesso sottovalutato è l’impatto delle aspettative del paziente sulla riuscita dell’ipnosi. La ricerca di Kirsch del 2011 ha dimostrato che le aspettative positive aumentano significativamente la suscettibilità ipnotica, mentre quelle negative la riducono. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei pazienti che hanno avuto esperienze negative precedenti o che nutrono pregiudizi verso l’ipnosi. Prima di iniziare qualsiasi intervento ipnotico, dedico sempre tempo a esplorare le credenze del paziente e a fornire informazioni accurate sulla natura scientifica dell’ipnosi. Utilizzo spesso la metafora del “pilota automatico” per spiegare come l’ipnosi non sia altro che un accesso consapevole ai processi mentali naturali che utilizziamo quotidianamente.
Per i pazienti che presentano resistenze persistenti, l’integrazione dell’ipnosi con altre tecniche può risultare particolarmente efficace. La ricerca di Alladin del 2016 ha mostrato come l’ipnosi cognitivo-comportamentale possa essere più efficace dell’ipnosi tradizionale in alcuni casi specifici. Un approccio che si utilizza frequentemente è l’integrazione dell’ipnosi con tecniche di EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Questo è particolarmente utile per pazienti che presentano traumi o esperienze negative associate al rilassamento. La combinazione delle due tecniche permette di aggirare le resistenze cognitive mantenendo l’efficacia.
È importante ridefinire il concetto di “successo” nell’ipnosi. Non tutti i pazienti devono necessariamente raggiungere stati di trance profonda per ottenere benefici. La ricerca di Jensen del 2017 ha dimostrato che anche livelli moderati di trance possono produrre cambiamenti significativi. Con i miei pazienti, utilizzo scale di valutazione soggettiva per monitorare i progressi, concentrandomi sui cambiamenti sintomatici piuttosto che sulla profondità della trance. Spesso, pazienti che si consideravano “non ipnotizzabili” ottengono risultati eccellenti in termini di riduzione dell’ansia, miglioramento del sonno o gestione del dolore. Lavorare con pazienti che presentano resistenze all’ipnosi richiede particolare attenzione agli aspetti etici. È fondamentale rispettare i tempi del paziente e non forzare mai l’esperienza ipnotica. La ricerca di Nash del 2012 ha evidenziato come la pressione possa aumentare le resistenze e compromettere la relazione. Mantengo sempre un approccio collaborativo, coinvolgendo il paziente nella scelta delle tecniche e rispettando le sue preferenze. Questo non solo migliora l’efficacia del trattamento, ma rafforza anche l’alleanza, elemento cruciale per il successo di qualsiasi intervento psicologico.
La mia esperienza clinica e la letteratura scientifica convergono su un punto fondamentale: non esistono persone completamente “non ipnotizzabili”, ma solo approcci che devono essere personalizzati e adattati alle caratteristiche individuali di ciascun paziente. L’ipnosi è uno strumento potente e versatile che può essere reso accessibile a tutti attraverso la competenza professionale, la pazienza e la creatività.
Se sei un paziente che ha avuto difficoltà con l’ipnosi in passato, non scoraggiarti. Ogni cervello ha la capacità di accedere a stati di coscienza modificati; si tratta solo di trovare la chiave giusta per aprire quella porta. Come professionisti, il nostro compito è accompagnarti in questo percorso di scoperta, rispettando i tuoi tempi e le tue modalità uniche di funzionamento.
L’ipnosi non è una destinazione, ma un viaggio. E ogni viaggio, per essere significativo, deve iniziare dal punto in cui ti trovi oggi, con le tue risorse, le tue resistenze e le tue infinite possibilità di cambiamento.