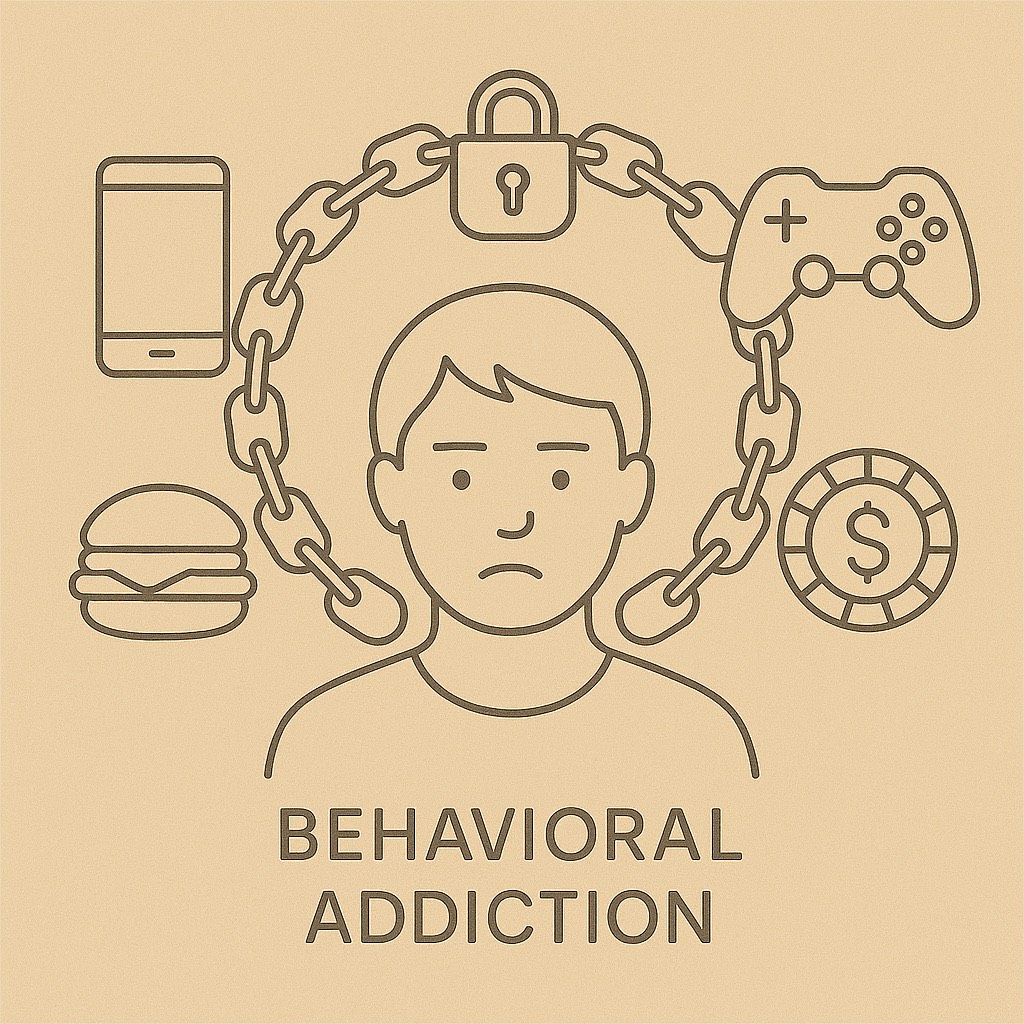“La nevrosi è sempre un sostituto di una legittima sofferenza.” Jung
Nel silenzio del mio studio, ascolto sempre più spesso storie che seguono uno schema ricorrente: persone intrappolate in comportamenti ripetitivi che portano momentaneo sollievo seguito da vergogna e disgusto; rituali che da piacevoli passatempi si sono trasformati in imperativi categorici; vite apparentemente funzionali che nascondono ore trascorse in attività compulsive. Sono i volti delle nuove dipendenze comportamentali, un fenomeno che merita una lettura profonda attraverso la lente psicodinamica.
Oltre la Sostanza: Quando il Comportamento Diventa Dipendenza
Le dipendenze comportamentali rappresentano un’evoluzione della comprensione classica dell’addiction. Se storicamente abbiamo associato la dipendenza a sostanze che alterano la chimica cerebrale, oggi riconosciamo che anche comportamenti apparentemente innocui possono attivare gli stessi circuiti neurobiologici della ricompensa, creando pattern di dipendenza altrettanto potenti.
Da una prospettiva psicodinamica, queste dipendenze non sono semplici abitudini sfuggite al controllo, ma risposte complesse a conflitti intrapsichici non elaborati che cercano risoluzione attraverso vie indirette e simboliche. Rappresentano tentativi – per quanto disfunzionali – di autoregolazione emotiva, di compensazione di vuoti identitari o di gestione di angosce primitive.
La Psicodinamica delle Nuove Dipendenze
Per comprendere queste dipendenze in profondità, dobbiamo andare oltre il comportamento manifesto e interrogarci sul significato simbolico che esso assume nella vita psichica dell’individuo. Dalla prospettiva psicodinamica, possiamo identificare alcuni meccanismi fondamentali:
1. Ripetizione traumatica e padronanza illusoria
Molte dipendenze comportamentali contengono elementi di ripetizione quasi traumatica. Come Freud ha osservato nel suo “Al di là del principio di piacere”, esiste nella psiche una compulsione a ripetere esperienze dolorose nel tentativo inconscio di padroneggiarle. Il trader che sviluppa dipendenza dai mercati finanziari potrebbe inconsciamente tentare di padroneggiare esperienze infantili di impotenza economica o imprevedibilità familiare.
2. Oggetti transizionali tecnologici
Winnicott descrisse l’oggetto transizionale come ponte tra realtà interna ed esterna, tra dipendenza e autonomia. Nella società digitale, dispositivi e piattaforme assumono spesso questa funzione transizionale patologica: lo smartphone diventa un oggetto-sé che media l’angoscia di separazione, ma paradossalmente impedisce una vera individuazione.
3. Difese narcisistiche e identità frammentate
Nelle dipendenze da social media o videogiochi, osserviamo frequentemente la creazione di identità alternative idealizzate che proteggono dal confronto con un Sé reale percepito come inadeguato. Queste difese narcisistiche, benché temporaneamente efficaci nel gestire la vergogna e l’inadeguatezza, contribuiscono a una progressiva frammentazione dell’identità.
4. Scissione e disregolazione degli stati affettivi
La dipendenza comportamentale spesso serve a scindere e proiettare parti inaccettabili del Sé. Il soggetto dipendente da pornografia, ad esempio, può proiettare sui contenuti digitali desideri percepiti come inaccettabili, mantenendo l’illusione di un Sé “pulito” nella vita quotidiana. Questa scissione, tuttavia, compromette l’integrazione psichica e alimenta ulteriormente il ciclo della dipendenza.
Le Manifestazioni Contemporanee
Dipendenza da Internet e Social Media
La dipendenza da internet rappresenta forse la manifestazione più emblematica del nostro tempo. Possiamo leggerla come risposta a bisogni relazionali frustrati: il soggetto cerca online il rispecchiamento e la validazione che non ha ricevuto nelle relazioni primarie. Le “microdosi” di dopamina liberate dalle notifiche e dai like replicano i pattern di rinforzo intermittente tipici delle relazioni di attaccamento insicuro, creando un ciclo di dipendenza particolarmente insidioso.
Maria, 35 anni, trascorre fino a sette ore al giorno su Instagram. In seduta emerge come questo comportamento rappresenti un tentativo di elaborare un trauma narcisistico adolescenziale: l’essere stata ignorata e svalutata dai pari. I like ricevuti funzionano come riparazioni simboliche di queste ferite, ma la validazione effimera che ne deriva alimenta un ciclo di vuoto-riempimento-vuoto che riproduce le dinamiche di un attaccamento insicuro-ambivalente con la figura materna.
Gaming Disorder
Nei casi di dipendenza da videogiochi, assistiamo spesso alla manifestazione di fantasie onnipotenti che compensano sentimenti profondi di impotenza e inadeguatezza. I mondi virtuali offrono ciò che la vita reale nega: controllo, prevedibilità, progressione lineare, riconoscimento immediato dei successi.
Marco, 22 anni, ha abbandonato l’università per dedicarsi a tempo pieno a un gioco di ruolo online. L’analisi rivela che il suo avatar – un potente guerriero rispettato nella comunità virtuale – rappresenta una formazione reattiva rispetto a un’immagine di sé caratterizzata da vulnerabilità e inadeguatezza. Il mondo virtuale gli consente di sperimentare un senso di agency e potenza che non ha mai sperimentato nella relazione con un padre ipercritico e dominante.
Shopping Compulsivo
Lo shopping compulsivo rappresenta spesso un tentativo di riempire un vuoto interno attraverso oggetti esterni. In una cultura che equipara l’avere all’essere, l’acquisto compulsivo diventa un tentativo illusorio di costruire un’identità attraverso beni materiali che fungono da estensioni narcisistiche del Sé.
Lucia, 42 anni, sviluppa shopping compulsivo dopo la morte della madre. Ogni acquisto ricrea momentaneamente la sensazione di pienezza e completezza che sperimentava nella relazione simbiotica con la figura materna, seguita inevitabilmente da un senso di vuoto che innesca nuovamente il comportamento compulsivo.
Dipendenza da Lavoro (Workaholism)
Particolarmente insidiosa perché socialmente valorizzata, la dipendenza da lavoro offre una via socialmente accettabile per evitare l’intimità relazionale e il confronto con parti vulnerabili del Sé. Freud ci ricorda che il lavoro, insieme all’amore, è una delle componenti fondamentali di una vita sana, ma quando diventa compulsivo rappresenta spesso una difesa dalla depressione o dall’angoscia.
Giorgio, 50 anni, dirigente di successo, lavora quattordici ore al giorno, inclusi weekend. In analisi emerge che questo comportamento rappresenta una difesa maniacale contro angosce depressive legate a un lutto infantile mai elaborato. L’iperattività lavorativa gli impedisce di confrontarsi con il vuoto interiore, mantenendo un’illusione di controllo e vitalità.
L’Approccio Terapeutico Psicodinamico
Il trattamento psicodinamico delle dipendenze comportamentali non si limita al controllo del sintomo, ma mira a comprendere e trasformare i significati inconsci e i conflitti sottostanti. Alcune direttrici fondamentali includono:
1. Creazione di uno spazio riflessivo
Prima ancora di affrontare direttamente il comportamento dipendente, è essenziale creare uno spazio riflessivo in cui il paziente possa iniziare a mentalizzare le proprie esperienze emotive. Molti pazienti con dipendenze comportamentali presentano alessitimia o difficoltà nella regolazione affettiva che precedono e alimentano la dipendenza stessa.
2. Esplorazione del significato simbolico
Piuttosto che demonizzare il comportamento dipendente, l’approccio psicodinamico esplora il suo significato simbolico: cosa rappresenta questo comportamento? Quali bisogni insoddisfatti cerca di colmare? Quali conflitti inconsci tenta di risolvere?
3. Elaborazione del lutto e integrazione delle parti scisse
Gran parte del lavoro terapeutico consiste nell’elaborazione del lutto per gli oggetti primari idealizzati o per parti del Sé non riconosciute. Questo processo permette una progressiva integrazione delle parti scisse e la rinuncia a soluzioni compensatorie disfunzionali.
4. Ricostruzione delle relazioni d’oggetto interiorizzate
Il lavoro analitico a lungo termine consente una progressiva modificazione delle relazioni oggettuali interiorizzate. La relazione terapeutica offre un nuovo modello relazionale che può essere gradualmente interiorizzato, sostituendo i pattern disfunzionali che alimentano la dipendenza.
5. Tolleranza dell’ambivalenza e dell’incertezza
Un obiettivo fondamentale del lavoro psicodinamico è lo sviluppo della capacità di tollerare stati affettivi ambivalenti senza ricorrere a comportamenti compulsivi. Questo processo richiede un’attenta modulazione della frustrazione all’interno del setting terapeutico.
Riflessioni Conclusive: Dipendenze Comportamentali nella Società Contemporanea
Le nuove dipendenze comportamentali possono essere lette come espressioni sintomatiche di un malessere più ampio che caratterizza la società contemporanea. L’accelerazione dei ritmi di vita, la frammentazione delle comunità tradizionali, la mercificazione delle relazioni e l’imperativo culturale dell’autosviluppo infinito creano un terreno fertile per queste manifestazioni patologiche.
Da una prospettiva psicodinamica, potremmo considerare queste dipendenze come tentativi disperati di trovare un senso di connessione e continuità in un mondo caratterizzato da discontinuità e frammentazione. Rappresentano, per usare un’espressione di Winnicott, tentativi di “sentirsi reali” in un contesto che promuove esperienze di derealizzazione e alienazione.
Come psicoterapeuti psicodinamici, siamo chiamati non solo a trattare il sintomo individuale, ma anche a riflettere criticamente sulle condizioni socio-culturali che favoriscono queste nuove forme di sofferenza. Il nostro compito, oggi più che mai, è creare spazi in cui sia possibile un’autentica elaborazione simbolica dell’esperienza, contro l’impoverimento della vita psichica che caratterizza molte dipendenze comportamentali.
La sfida più grande, forse, è quella di aiutare i nostri pazienti a sviluppare una relazione con la tecnologia e con i comportamenti potenzialmente addittivi che non sia né di fusione acritica né di rifiuto fobico, ma di integrazione consapevole all’interno di un’identità sufficientemente solida e flessibile.
In un’epoca in cui la disconnessione è diventata un lusso e l’attenzione una risorsa scarsa, offrire uno spazio di presenza attenta e non giudicante rappresenta forse il contributo più rivoluzionario che la psicoterapia psicodinamica possa offrire.
I nomi dei pazienti sono frutto di fantasia